B. Melanovic. Ingiustizia globale. Ed. Luiss 2017, Roma.
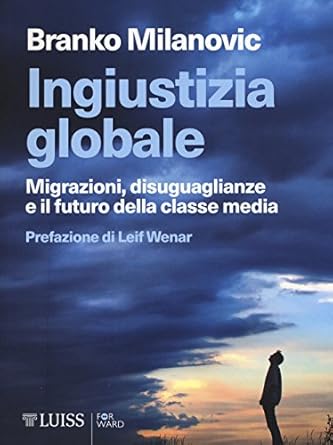
Introduzione
La globalizzazione esercita impatti enormi sulle nostre vite: sui livelli di reddito, sulle possibilità di impiego, sui costi delle merci, sulle informazioni di cui disponiamo. Nonostante questo circa 2/3 del reddito che accumuliamo nel corso della nostra vita dipende dal Paese in cui siamo nati e nel quale viviamo. Sembra una contraddizione il fatto che in un mondo così interconnesso, dove capitali, merci e persone (non tutte, purtroppo) 0circolano liberamente senza più confini, le caratteristiche dello stato nazione in cui si è nati esercitino ancora tanta influenza sulle nostre traiettorie esistenziali. Ma della globalizzazione non possono fruire tutti allo stesso modo. Ad esempio, nell’occidente industrializzato c’è chi si avvantaggia e chi perde. Dipende dal grado di istruzione e dalle opportunità che si aprono di fronte a noi. E queste possibilità, a loro volta, sono legate al Paese in cui nasciamo e cresciamo, oltre che dai genitori che ci hanno messo al mondo.
Cap.1
Negli ultimi decenni, in quasi tutto il mondo, sono aumentate le disuguaglianze di reddito. Dagli anni 80 fino al 2016 il 27% della crescita totale di reddito è andato all’1% più ricco, mentre il 12% è andato al 50% più povero. Il grafico dell’elefante di Melanovic mette in relazione la crescita cumulata del reddito (in percentuale rispetto all’anno di base 1988) nel 2008 a seconda del ventile di appartenenza nella distribuzione del reddito a livello globale. Il grafico dimostra che nel ventennio ha guadagnato la classe media globale (collocata tra il valore della mediana + - 25%, che per il 90% appartiene alle economie emergenti asiatiche (in valori assoluti nel 2008 siamo intorno a un reddito familiare pro-capite di 1400 dollari), ha perso la classe media inferiore dei Paesi ricchi (facenti parte di economie stagnanti). Si tratta dei percentili di reddito attorno all’80% della distribuzione globale, per i ¾ corrispondenti con cittadini dei Paesi ricchi. Nei Paesi ricchi la globalizzazione ha favorito chi era più abbiente. Se si considerano i guadagni assoluti, la parte acquisita dai più ricchi diventa di gran lunga preponderante. La crisi del 2008 non è quindi globale, ma “atlantica” perché ha comportato la recessione nelle economie atlantiche. La Cina si è arricchita molto, tanto che ora registra un reddito medio + elevato, a parità di potere di acquisto, rispetto a diversi Paesi membri della Ue come Romania, Lettonia, Lituania. I redditi e i consumi costituiscono variabili di flusso. La ricchezza, invece, è una misura di stato, rappresenta il livello di accumulo di risparmi, redditi, eredità… La ricchezza ha una distribuzione più disuguale del reddito. E’ anche intuitivo. Persino nei Paesi ricchi tra ¼ e 1/3 della popolazione ha una ricchezza netta pari a 0 o negativa. A livello globale l’1% più ricco detiene il 16% del reddito e il 46% della ricchezza. Esistono poi i plutocrati, un gruppetto di circa 1500 persone con un patrimonio superiore al miliardo di dollari. Controllano circa il 2% della ricchezza mondiale, circa 2 volte il patrimonio esistente nel continente africano. Cresce la plutocrazia con riflessi politici importanti per il presente e futuro del mondo. Dagli anni 50 del 900 fino alla fine del secolo in molti Paesi europei con uno stato sociale forte anche i più poveri non stavano male se confrontati a un livello globale. Appartenevano, infatti, al quintile più alto a livello mondiale, al 20% superiore nella distribuzione del reddito.
Cap. 2 Disuguaglianza interna ai Paesi
La curva di Kuznets è un’astrazione che non ha riscontro con l’andamento effettivo delle disuguaglianze al variare del reddito pro-capite. Milanovic parla di onde cicliche che ne spiegano meglio l’andamento. In epoca anteriore alla prima rivoluzione industriale, nelle economie stagnanti di quel periodo, le disuguaglianze oscillavano attorno a una media più o meno fissa. Potevano crescere solo con lo sviluppo del commercio, come avvenne attorno alla metà del 500 e con l’apertura di nuove rotte commerciali. Diminuiscono con guerre, epidemie, carestie. Se, infatti, il reddito medio pro-capite si avvicina alla sussistenza, le disuguaglianze tendono a annullarsi. Le oscillazioni erano legate fondamentalmente ai cicli malthusiani. Dopo la rivoluzione industriale, a metà dell’800, le disuguaglianze sono cresciute fino a raggiungere il loro massimo in coincidenza con l’inizio della prima guerra mondiale. Da allora e fino al 1980 le disuguaglianze sono continuate a diminuire. Dal 1980 hanno ripreso un ciclo ascendente. Le forze che le fanno aumentare sono rappresentate dall’aumento del reddito pro-capite, della urbanizzazione, dei progressi tecnologici, del maggior incremento dei tassi di rendimento dei redditi di capitale rispetto al tasso di rendimento dei redditi da lavoro. La flessione è spiegata da guerre, carestie, da una maggiore progressività fiscale. Essa continua dopo la seconda guerra mondiale grazie anche alla forza dei partiti di sinistra, il potere dei sindacati, il potenziamento del welfare, dell’istruzione, dei servizi sanitari e sociali. Dal 1980, con la seconda rivoluzione tecnologica (quella informatica) e una più accentuata globalizzazione, l’avanzata delle aziende di servizio a scapito di quelle manifatturiere (+ eterogenee, + dislocate, + piccole) e in seguito alle ondate neoliberistiche scatenate dalla Tatcher e da Reagan, le disuguaglianze sono riprese a salire dando luogo a un’altra onda ciclica. A parte le politiche manifestamente favorevoli ai + abbienti, è obbiettivamente difficile tassare capitali mobili che con la globalizzazione e la diffusione di tecnologie informatiche si spostano da una giurisdizione all’altra. Ha contribuito anche l’automazione dell’industria. Le macchine sono più docili dei lavoratori. L’Italia è il Paese che ha fatto registrare l’aumento più significativo del reddito pro-capite tra l’anno della sua unificazione (1861) e il 1980 (9 volte) per via della sua rapida crescita dopo la seconda guerra mondiale (il miracolo italiano vedi tabella pag 90). La storia ci ha insegnato quanto sia distruttivo l’incremento del livello di disuguaglianza sfociato nella prima guerra mondiale. Dobbiamo investire in un processo pacifico di contenimento delle disuguaglianze dal momento che ci sono noti i fattori benigni che possono attenuarle. Soprattutto: tassazione progressiva, tasse +alte sulle successioni, istruzione, ma realisticamente non si può pensare di superare una media di 13 anni di scuola) convergenza dei redditi globali (ndr è più vicina la convergenza di salute), anche la tecnologia a favore dei lavoratori a + bassa qualifica per aumentarne la produttività.
Cap 3 Disuguaglianza tra Paesi
Nel 1820, prima della rivoluzione industriale, solo il 20% della disuguaglianza globale era dovuto alla disuguaglianza tra Paesi. Il restante 80% era attribuibile alla disuguaglianza tra le classi sociali interne ai Paesi. Verso il 1950 le percentuali si capovolgono. Il 20% della disuguaglianza globale è attribuito alla disuguaglianza tra le classi sociali. La disuguaglianza globale dipende, quindi, per l’80%, da dove si nasce. Nascere in un Paese ricco contava molto di più che nascere in una famiglia benestante. C’è un premio di cittadinanza per chi nasce in un Paese giusto e una penalità di cittadinanza per chi nasce in Paesi sbagliati. Questo fattore apre una questione economica legata ai fenomeni migratori e una questione filosofica legata al fatto di poter difendere il “premio di cittadinanza” sulla base di considerazioni connesse con la giustizia. E’ probabile che nel futuro ritorneremo a una situazione simile a quanto si vedeva a inizio 800, per via della convergenza economica e sanitaria. Il premio di cittadinanza rispetto al Congo (tra i Pasi più poveri) è di 9200%: ossia, per i corrispettivi percentili di reddito un cittadino Usa ha un reddito di 92 volte superiore a quello di un cittadino del Congo. Il premio di cittadinanza in Svezia, sempre rispetto al Congo, per il decile più basso sale a 10400% (la Svezia è meno sperequata rispetto agli Usa). La mobilità inter-generazionale è oggi più alta nei Paesi del nord Europa che negli Usa. Le migrazioni in genere impoveriscono i Paesi di origine. Per la teoria della giustizia di John Rawls (1971), all’interno di ogni Paese andrebbe posto rimedio alle disuguaglianze immeritate (di nascita o per doti naturali). I migranti sono poco più del 3% della popolazione globale. Migranti sono coloro che risiedono in un Paese diverso da quello in cui sono nati. Sono in aumento. Ma quelli cui piacerebbe trasferirsi sono il 16% circa, la stessa proporzione di migranti presente negli Usa e in Spagna. Potrebbe essere una soluzione attenuare la deterrenza per i migranti che spesso vivono in condizioni di clandestinità e prevedere 2 o 3 gradi diversi di cittadinanza per chi arriva.
Cap 4’ disuguaglianza globale
Con la globalizzazione la disuguaglianza globale dovrebbe ridursi. Ci si aspetta che diminuisca il divario tra Paesi, e i Paesi poveri crescano a un ritmo più sostenuto (4,7%) rispetto a quelli ricchi (1%). Dovrebbe anche aumentare l’istruzione, l’accesso alla tecnologia e la domanda di una maggiore sicurezza sociale. Verso una maggiore eguaglianza conducono anche le guerre (che sono combattute dai poveri, finanziate dai ceti medi e avvantaggiano i ricchi). I Paesi emergenti asiatici sono quelli che corrono di più, i Paesi africani sono più lenti. La disuguaglianza si acuisce quando i capitalisti ricchi sono anche quelli che ricevono un reddito più elevato, come accade ora. L’accettabilità sociale della ricchezza è rafforzata dal fatto che i ricchi lavorano sodo e hanno carriere di successo costellate da molti meriti (ndr ma c’è il problema di una quantità di denaro eccessiva, nemmeno immaginabile!). Da un punto di vista politico, la sensibilità dei legislatori è tutta concentrata sulle preoccupazioni e i problemi dei ricchi. Sono loro che spendono miliardi per finanziare le campagne elettorali e per attività lobbistiche. Al posto di un sistema “una testa un voto” si instaura un sistema “un dollaro un voto”, per cui i voti non si contano, si pesano. La disuguaglianza non minaccia la persistenza del capitalismo perché non esistono alternative realistiche da porre al suo posto. Ad esempio, Cina e Russia attuano un capitalismo di Stato in cui sono dominanti il motore del profitto privato e le società private. Il socialismo a pianificazione centrale è stato eliminato. Sebbene l’egemonia del capitalismo sembri quasi inattaccabile, l’eccessiva disuguaglianza che provoca mette in evidenza i suoi lati spiacevoli: l’enfasi materialistica, l’ideologia del chi vince prende tutto, l’indifferenza per motivazioni che non siano pecuniarie. Le eccessive disuguaglianze si conciliano male con le democrazie liberali. Sfociano nella plutocrazia, come avviene negli Usa o nei populismi come avviene in Europa. La classe media vede diminuito il suo potere di acquisto. Il suo indebolimento porta a un calo di sostegno per l’istruzione e la sanità e il welfare in generale. I ricchi preferiscono rafforzare le operazioni di polizia o i lavori di sorveglianza. La produzione si sposta verso i beni di lusso. Con la plutocrazia il denaro svolge un ruolo fondamentale nelle decisioni politiche. La strada verso questa deriva è stata aperta con la decisione della Corte suprema di trattare le società di capitali come individui giuridici. L’opinione pubblica viene manipolata affinché concordi con l’opinione dei finanziatori di tv, giornali, piattaforme sociali. Il welfare state europeo è stato costruito sulla presunzione di un’omogeneità etnica e culturale della popolazione. Se qualcuno finge di essere malato o più vecchio del vero, il welfare state si sgretola. In seguito all’assottigliamento del ws, la classe media e quella media-inferiore si è spostata verso destra per via di mancanza di alternative all’interno di una sinistra screditata dopo la caduta del comunismo, cooptata e snaturata da parte di partiti di centro, incapace di rappresentare le istanze delle classi più disagiate. Il populismo è contro le immigrazioni, revoca alcuni diritti fondamentali del cittadino (diritti civili), è antieuropeista. Le difficoltà dell’Europa nei confronti delle immigrazioni sono dovute al fatto che siamo stati a lungo terre di emigrazione, gli Stati-nazione sono tendenzialmente omogenei da un punto di vista etnico o, comunque, le eventuali differenze etniche sono state riassorbite, nel tempo, dalla cultura. Si hanno problemi ad assimilare gli immigrati non solo di 1’, ma anche di 2’ o 3’ generazione. Ndr caratteristiche italiane: 1 presenza forte di lavoro autonomo a basso reddito 2 classe operaia di piccole e medie imprese 3 scarso sviluppo della classe professionale e manageriale. I professionisti hanno redditi medi e bassi. L’Italia non è un Paese per laureati. Dai primi anni 90 si è verificata un’erosione dei salari e un indebolimento dei ceti medi a causa della crisi del lavoro autonomo. La competitività si basa sui bassi salari. Con le partite iva si copre la subordinazione con la maschera della consulenza.
Cap 5’ E il futuro?
Per diminuire la disuguaglianza globale occorre che crescano altri Paesi oltre alla Cina. Il declino della classe media dei Paesi industrializzati è dovuto alla globalizzazione e all’automazione. Il caso e il contesto familiare giocheranno un ruolo ancora più importante rispetto al passato. L’equilibrio di potere si è spostato dalla parte dei capitalisti. E’ difficile tassare i capitali data la loro mobilità. Bisogna ridurre le disuguaglianze nelle proprietà e nell’istruzione. A questo fine sono importanti le tasse di successione e l’equità nell’accesso significativo all’istruzione (tenendo presente che un anno di Harvard non vale come un anno in un’università statale di basso grado. Occorre riequilibrare la qualità dell’istruzione nelle varie scuole). Accanto alle strategie redistributive ci sono anche quelle pre-distributive (l’istruzione) e distributive (salario minimo, tetto alle retribuzioni..), politiche per imposte sui redditi delle società che stimolerebbero le aziende a distribuire quote societarie ai lavoratori (spostandosi verso un sistema di capitalismo a responsabilità dei lavoratori). La regola del “chi vince piglia tutto” è esemplificata dai lavori scalabili”, ossia quelli in cui la stessa unità di lavoro individuale può essere venduta molte volte (es. pianista, tennista, attore, influencer, brevetti, predicatori televisivi..). Per tutti gli altri lavori il reddito è condizionato dal numero di unità di lavoro prodotte. L’Europa dovrà prioritariamente definire una linea politica multilaterale sul lavoro e le migrazioni coinvolgendo anche i Paesi di origine. Dobbiamo cambiare il carattere binario delle regole attuali di cittadinanza nazionale. Si intende, così, attenuare le riluttanze attuali dei cittadini a condividere il loro premio di cittadinanza coi migranti. Si dovrebbe introdurre un grado intermedio di cittadinanza meno prezioso (vedi pag 214). Per quanto riguarda la crescita non si dovrebbe perseguire la decrescita (Ndr si dovrebbe essere agnostici rispetto alla crescita come invita a fare K. Raworth, ma alzare i tassi di crescita dei Paesi poveri anche per contenere le migrazioni. Bisogna, invece, porre dei freni alla c)rescita dei ricchi per i cui redditi valgono delle leggi di potenza. L’interesse degli studi statistici deve spostarsi dalle medie pro-capite alla variabilità delle stime. Finora si è preso lo Stato-nazione come naturale unità di analisi. Gli studi sulle disuguaglianze globali trascendono i limiti del nazionalismo metodologico. Di fronte ai problemi che interessano tutti i popoli della terra, gli strumenti di cui ci avvaliamo sono obsoleti. Sono necessari nuovi modi di osservare la realtà.