Saito Kohei. Il capitale nell’antropocene. Einaudi 2024, Torino.
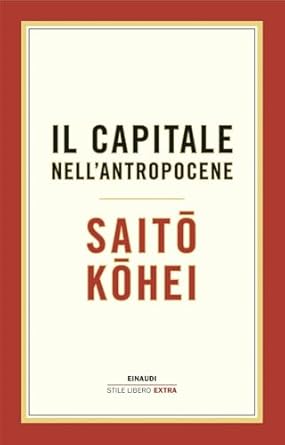
Prefazione
Prima della rivoluzione industriale la concentrazione di CO2 nell’atmosfera era di 280 ppm. Oggi ci avviamo a superare 400 ppm. E questo è un evento nuovo che non si verifica da 4 milioni di anni. Allora la temperatura era di 2-3 gradi superiore a quella odierna, la calotta di ghiaccio che ricopre la Groenlandia e l’Antartide era sciolta, e il livello dei mari era più alto di almeno 6 m. La crescita economica conseguente alla rivoluzione industriale e all’avvento del capitalismo è alla base della crisi ambientale da cui stiamo per essere travolti.
Capitolo 1
Stante il già attuale aumento della temperatura di più di 1 grado, per contenerlo entro 1,5 gradi alla fine del secolo bisognerebbe dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 e azzerarne le emissioni nette entro il 2050. La globalizzazione ha comportato lo sfruttamento di interi popoli e delle loro risorse naturali. Il costo della nostra agiatezza grava, in gran parte, sulla popolazione del Sud globale. Acquistando a prezzi stracciati le materie prime e i prodotti del Sud globale e sfruttando la sua manodopera, i Paesi ad alto reddito hanno accumulato un profitto sempre maggiore. Attraverso questo scambio iniquo si è determinato il sotto-sviluppo dei Paesi a basso reddito e il sovra-viluppo dei Paesi avanzati. I Paesi avanzati sono società esternalizzanti perché dirottano i costi reali dei loro scambi sulla natura e sulla popolazione di qualche luogo lontano. Per via della lontananza questa violenza ci risulta quasi invisibile. Ma sono sempre meno i Paesi da sfruttare. E , ormai, a causa delle devastazioni ambientali, la crisi climatica investe tutti, anche se con maggiore o minore violenza. Si è assistito a una grande accelerazione dopo la fine della guerra fredda. Tanto che circa la metà del totale dei combustibili fossili utilizzati dal genere umano sarebbe stato consumato a partire dal 1989. Pe risolvere la crisi ambientale si punta sulla tecnologia. Ad esempio, agli inizi del 900 il processo di Haber-Bosh portò alla sintesi industriale dell’ammoniaca per rimediare all’impoverimento del suolo dovuto all’attività agricola. Ma così facendo si aumentò la dispersione dei composti azotati e l’emissione di CO2. Occorre essere cauti. Le esternalizzazioni vengono in parte occultate dal dirottamento dei costi in luoghi lontani. E anche dal fatto di vederne l’impatto non immediatamente, ma a distanza di tempo. La CO2, infatti si accumula. Si dice che, emettendo, oggi, 10 molecole di CO2, 3 o 4 le ritroveremo ancora dopo un secolo e 1 anche dopo un millennio. La crisi climatica, la crisi del sistema agro-industriale, quella energetica, quella migratoria portano a richiuderci in noi stessi sperando di salvarci da soli. Queste crisi nutrono anche un nazionalismo rabbioso fondato sull’esclusione e sulla xenofobia. Ci rendiamo conto di dover modificare i nostri stili di vita. La legittimità del sistema capitalistico, che ci induce a produrre e consumare sempre di più, vacilla sotto la spinta del deterioramento sociale e ambientale.
Capitolo 2
Il capitalismo non si limita a depredare l’essere umano, ma depreda anche l’ambiente. La crescita economica che persegue viene enormemente sussidiata dalla esternalizzazione dei suoi costi umani e ambientali. Il green new deal, nella sua veste reale, finisce per essere un baluardo di difesa della consueta conduzione degli affari da parte del capitalismo. In realtà, le opzioni sono 2: o la crescita o il contenimento della crisi. Non è possibile disaccoppiare la crescita dal peggioramento della crisi ambientale. La diminuzione delle emissioni di CO2 nei Paesi sviluppati è, in realtà, un artefatto provocato dalle delocalizzazioni della produzione. Per di più, le merci sono consumate lontano dai posti dove vengono prodotte e in cui si estraggono le materie prime. La crescita economica del XX secolo è stata resa possibile dall’uso intensivo dei combustibili fossili. Oggi le energie rinnovabili non vanno a sostituire l’energia dei combustibili fossili, ma, almeno in gran parte, si aggiungono ad essa. L’effetto delle rinnovabili viene vanificato dal rimbalzo dei consumi. La metà complessiva delle emissioni globali viene prodotta dal 10% più agiato della popolazione totale. Non è possibile un futuro sostenibile senza modificare gli stili di vita. La dematerializzazione ottenuta attraverso gli investimenti nel settore dei servizi non può rappresentare la soluzione. Ad esempio, anche la produzione dei computer e il loro funzionamento richiedono grandi quantità di energia. Dovremmo arrivare a modelli di consumo analoghi a quelli della seconda metà degli anni 70.
Capitolo 3
Non è possibile promuovere il progresso nei Paesi a basso reddito adottando gli stessi modelli pre-esistenti nei Paesi sviluppati. ( Ndr si ricordi la frase di Einstein a questo proposito). Comunque, superare la soglia della povertà e della fame costerebbe poco secondo Kate Raworth. Per la nutrizione basterebbe l’1% dell’offerta attuale di calorie. L’accesso universale all’elettricità comporterebbe un incremento di emissioni dell’1%. Per sconfiggere la povertà basterebbe lo 0,2% del Pil globale. La democrazia, l’uguaglianza di genere e una minore disuguaglianza socio-economica non costerebbe nulla. Si deve puntare sull’equilibrio e non sulla crescita perché, superata una certa soglia, la crescita non è più correlata con la qualità della vita. La decrescita, al contrario di ciò che pensano studiosi autorevoli come la Raworth e Stiglitz, secondo Saito non è compatibile con il capitalismo. Il capitalismo, infatti, è un sistema che per accrescere il valore e l’accumulo di capitale, crea continuamente nuovi mercati. In questo processo sottrae risorse alla natura e all’essere umano. Se aumentano gli incendi si possono vendere assicurazioni, se aumentano le cavallette, si vendono i pesticidi, se aumentano le guerre, si vendono le armi, se il suolo viene degradato si vendono i fertilizzanti…. Il capitalismo comporta privatizzazioni, allentamento delle regole, espansione dei mercati finanziari. Si può credere ancora nella teoria della tracimazione? A quanta crescita dobbiamo ancora assistere perché si ottenga un vantaggio in termini di benessere? In realtà, aumentano le disuguaglianze socio-economiche, le emissioni, l’inquinamento, i problemi della bio-diversità. Chi non ha denaro viene privato dei diritti basilari. Il green new deal nasce in opposizione al neo-liberismo, ma si muove all’interno di un sistema capitalistico, dove la decrescita diventa stagnazione e recessione. L’opinione dell’autore è più radicale. Non basta mettere le redini ai principi di mercato neoliberistici per mezzo di una politica statale di welfare di ispirazione social-democratica: aumentare il salario dei lavoratori, rinforzare i sindacati, adottare una tassazione progressiva capace di procurare un gettito fiscale atto a sostenere il welfare. Il capitalismo, infatti, avrebbe le armi per difendersi e aggredire con la minaccia di trasferire le fabbriche all’estero, di far precipitare i titoli di borsa e di condizionare le politiche dei governi. Nonostante le buone intenzioni, la transizione verso una decrescita e un’economia stazionaria non potrà realizzarsi. (Vedi Smil sul fatto che il fenomeno della crescita è relativamente recente….)
Capitolo 4
La critica al capitalismo va abbinata alla elaborazione di un modello di futuro post-capitalista. Se l’alternativa al capitalismo è il comunismo, allora si può dire che non esiste un’alternativa praticabile. A meno che si reinterpreti Marx alla luce del concetto di bene comune: una ricchezza condivisa dalle persone, che è necessario gestire a livello sociale. Si apre, così, una terza via tra il neoliberismo americano e la nazionalizzazione sovietica. L’acqua e il terreno fertile, per quanto riguarda l’ambiente; l’elettricità e i trasporti, per le infrastrutture; l’educazione e la sanità per la società: sono tutti beni comuni da amministrare e gestire a livello di comunità senza affidarli a norme statali o a standard di mercato. L’origine dei servizi statali nel tempo nasce nel XX secolo dalla istituzionalizzazione dell’esigenza di una maggiore sicurezza sociale (previdenza sociale, pensioni, infortuni, malattie, disoccupazione, vecchiaia). Non nacquero su iniziativa dei governi, ma di sindacati, cooperative, organizzazioni e partiti operai. A partire dagli anni 80, però, le politiche di rigore introdotte dal neoliberismo hanno indebolito i sindacati e le associazioni, tanto che il bene pubblico è stato divorato dal mercato. Nel manifesto del partito comunista Marx e Engels sostenevano che gli operai erano sfruttati, che i capitalisti, spinti dalla competizione, incrementano la produzione, ma i prodotti non possono essere acquistati dagli operai impoveriti, che la sovra-produzione porta a una crisi economica e che la crisi economica conduce alla rivoluzione socialista. E’ vero che il capitalismo sfrutta persone e ambiente. Ma la competizione stimola anche l’innovazione e l’aumento della produzione crea le condizioni per cui tutti diventiamo più ricchi. Questa è una visione progressista della storia, anche chiamata materialismo storico. Ma questo primato della produzione ignora i danni recati a uomini e ambiente, per cui il marxismo è stato criticato dagli ambientalisti. Lo stesso Marx si allontana da questa visione progressista della storia per abbracciare, sulla base degli insegnamenti di Liebig, il concetto di metabolismo e ricambio organico tra uomo e natura che si compie respirando, nutrendosi e attraverso gli escrementi. Il ciclo senza fine con cui il capitale incrementa il valore non è compatibile con il ciclo naturale. Bisogna, perciò, passare a un altro sistema economico, il socialismo, e perseguire una crescita economica sostenibile. Questa è la posizione di eco-socialismo che Marx cominciò ad abbracciare alla pubblicazione del primo libro del Capitale (1867). Furono necessari studi in campo ecologico e ricerche sulla comunità precapitalistiche non occidentali. I popoli germanici possedevano la terra in comune e vietavano la compra-vendita di terreni, maiali, vino, legname e altre merci al di fuori della loro comunità. Il pascolo era accessibile a tutti secondo regole condivise e sorteggi che ne regolavano l’uso periodico. Sostenibilità ed eguaglianza sociale erano principi molto interconnessi. Nelle comunità si produceva secondo la tradizione, l’economia non cresceva, era stazionaria e ciclica. Anche di fronte alla possibilità di lavorare e produrre di più non lo facevano. Sceglievano, così, di prevenire la formazione di relazioni di potere, di dominio e sottomissione.
Capitolo 5
L’aumento della popolazione mondiale e la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo rischiano di portarci a un punto di non ritorno della crisi climatica. E’ irrealistico puntare sulla politica perché la politica è subordinata all’economia. Oggi dilaga il lavoro “stupido”. I lavoratori perdono progressivamente la loro capacità di ideazione a causa della mancanza di esercizio. La coppia ideazione-esecuzione si è separata. Dobbiamo cambiare il nostro stile di vita (Ndr vedi l’abbondanza frugale di La Touche) e scoprire una nuova abbondanza al suo interno. Non è più tollerabile che le 26 persone più ricche del mondo detengano le stesse ricchezze di 3,8 miliardi di persone che vivono in povertà. Noi che siamo soliti associare al capitalismo ricchezza e abbondanza non dovremmo aprire gli occhi e pensare, invece, che sia vero il contrario?
Capitolo 6
Molti alloggi nelle città non sono destinati ad essere abitati, ma ad essere venduti in operazioni speculative. Cresce il numero degli appartamenti vuoti. Si genera una scarsità di offerta che fa aumentare i prezzi degli affitti. Gli affitti crescono e gli inquilini vengono sfrattati. I ceti popolari vanno ad abitare altrove, cambia la composizione sociale degli abitanti (gentrification). Col termine di accumulazione originaria ci si riferisce al processo di recinzione, alla espulsione dei contadini dalla gestione in comune della terra coltivata, dei boschi e dei pascoli. I contadini impoveriti diventarono operai salariati nelle fabbriche. Le recinzioni generarono il capitalismo. L’aumento della ricchezza privata comporta la riduzione della prosperità pubblica. Se si riesce a creare scarsità d’acqua, ecco che allora può essere imbottigliata e commercializzata. Ciò che è importante per la prosperità pubblica non è il valore di scambio dato dal denaro, ma il valore d’uso. L’essenza del neoliberismo consiste nel processo per cui l’èlite dei ricchi si appropria della ricchezza comune per mezzo dello Stato. In sintesi, i beni comuni costituiscono un valore d’uso per tutti, sono accessibili gratuitamente. Quando si crea artificialmente la scarsità è possibile attribuire un prezzo a questi beni. Anche la distruzione e lo spreco costituiscono un’occasione per il neoliberismo, dal momento che producono scarsità. Anche il cambiamento climatico diventa un’occasione di affari perché produce scarsità di acqua e di terre coltivabili. L’industria del marketing è diventata la terza più grande al mondo dopo cibo ed energia. Si aumentano, così, i consumi e ci si indebita per soddisfare i propri desideri. Anche l’elettricità dovrebbe essere garantita come un diritto umano. Un esempio è la diffusione delle energie rinnovabili attraverso le comunità energetiche. Quando la fonte di energia è decentralizzata, come nel caso dell’energia solare, non può essere monopolizzata. Anche i mezzi di produzione possono diventare comuni attraverso le cooperative dei lavoratori che promuovono un’economia sociale solidale che reinveste nella comunità attraverso la formazione e la gestione diretta delle attività. Il principio di fondo è non lasciare indietro nessuno, in opposizione a un neoliberismo che crea povertà, discriminazione, disuguaglianza. Con la valorizzazione dei beni comuni, gli ambiti che possono essere commercializzati si riducono, di conseguenza il Pil diminuisce, ma non è detto che diminuisca il benessere delle persone. Non è vero che si debba sopportare una vita di miseria per proteggere l’ambiente. Occorre definire dei limiti (vedi Raworth). Lo si fa tramite un processo politico che comporta decisioni in ambito economico, sociale ed etico. E’ essenziale l’auto-regolamentazione del consumatore.
Capitolo 7
Così come è avvenuto per la pandemia, potrebbe succedere anche in occasione di altre crisi, ad esempio quella climatica, che il potere statale appaia soverchiante. In seguito a queste tensioni le istituzioni potrebbero collassare e non godere più del sostegno popolare. Anche perché la crisi climatica si accompagnerà con la scarsità di cibo e acqua. Bisogna sviluppare, quindi, capacità di autogoverno e aiuto reciproco, altrimenti si aggravano le divisioni. Piketty propone un socialismo partecipativo che non sia solo un capitalismo addomesticato, ma una nuova prospettiva di equità di portata universale, basata sulla proprietà sociale, sull’istruzione e sulla condivisione della conoscenza e dei poteri. Si tratta di un socialismo che vada oltre la semplice redistribuzione tramite un’autentica progressività fiscale e adeguate imposte di successione: un socialismo che preveda la proprietà sociale dell’azienda e la partecipazione alla gestione da parte dei lavoratori. A Copenaghen, ad esempio, si sono piantati alberi da frutta a disposizione di chiunque ne voglia raccogliere i frutti. Ma è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo! 5 punti fondamentali per Marx sono: - passare ad un’economia che valorizzi il valore d’uso; - la riduzione dell’orario di lavoro - l’abolizione della divisione standardizzata del lavoro; - la democratizzazione del processo produttivo; - l’importanza dei lavori essenziali (produrre ciò che è davvero necessario alla prosperità delle persone, no a marketing, pubblicità e confezionamento). Al capitalismo non interessano il valore d’uso delle merci, la loro qualità e l’impatto ambientale. Occorre rendere il lavoro attraente, occasione di realizzazione personale e di creatività. Bisogna evitare il monopolio sulla proprietà individuale e sulle piattaforme, anche se questo potrebbe rallentare la velocità dell’innovazione. L’assistenza alla persona è un settore ad alta intensità di lavoro. I lavoratori vengono, però, vessati da manager incapaci che aumentano il carico amministrativo e le pratiche inutili. Produce un valore d’uso elevato, ma viene pagato poco rispetto a lavori che producono poco valore d’uso, come il marketing, la pubblicità e la finanza.
Capitolo 8
Va ideata una nuova logica urbana che preveda la creazione di altri spazi verdi, l’autosufficienza energetica e alimentare, il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblici, limitazioni all’uso di automobili, isole pedonali, piste ciclabili, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, la disponibilità di alloggi popolari, la municipalizzazione degli acquedotti… Bisogna promuovere l’economia solidale in cui operano le cooperative dei lavoratori, associazioni dei consumatori, gruppi di consumo e mutue di assistenza. Occorre affidare gli appalti pubblici ad aziende con adatti prerequisiti. Nessuno va lasciato indietro. Il movimento dei contadini di via Campesina coinvolge 200 milioni di agricoltori in tutto il mondo. Lottano a favore della giustizia climatica e della sovranità alimentare. Il cibo dovrebbe essere un bene comune. Vanno aperte nuove strade alla solidarietà internazionale, alla giustizia sociale e climatica. Il marxismo non è in grado di presentare una reale alternativa radicale. L’Unione sovietica ci ha dato un esempio di gestione statale delle imprese in una forma di “capitalismo di stato”. Dal canto suo il neoliberismo ha condotto a uno sfruttamento ancora più intenso della classe lavoratrice e della natura. E’ certo meglio pretendere dallo Stato di far circolare la ricchezza anche tra i lavoratori promuovendo politiche anti-austerità e maggiori investimenti pubblici. Ma la semplice richiesta di politiche anti-austerità non basterebbe a fermare il saccheggio delle risorse naturali. Si criticano anche gli obbiettivi Onu 2030. NDR occorre pensare seriamente all’abbondanza frugale di La Touche. Occorre promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e sistematizzare un processo attraverso cui le loro opinioni siano raccolte dallo Stato, discutendo sul significato del lavoro, della vita, della libertà e dell’eguaglianza. Occorre promuovere l’interazione tra movimenti sociali e politici.
Conclusione
Secondo una politologa dell’università di Harvard, quando il 3,5% delle persone si mobilita con intenzioni serie e metodi non violenti, le società vanno incontro a grandi cambiamenti. In passato, a causa della nostra indifferenza, è bastato l’1% della popolazione, quella più ricca, a cambiare norme e regole e a trasformare la società secondo i loro interessi. Non dobbiamo più permettere che tutto questo continui allo stesso modo, come se niente fosse.